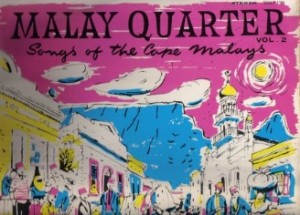 Il grande Jorge Luis Borges scrisse tutta la vita del mistero dell‘inconoscibile che gioca a nascondino tra le pieghe della realtà.
Il grande Jorge Luis Borges scrisse tutta la vita del mistero dell‘inconoscibile che gioca a nascondino tra le pieghe della realtà.
Non parlò mai, però, dell’enigma della Matriciana, né delle generazioni che da secoli si interrogano sul significato esoterico del guanciale.
Forse perché non scrisse mai di cibo.
Strano: avrebbe avuto molto materiale. L’esperienza gastronomica è piena di tanti piccoli Aleph, come li chiamava lui, in cui la memoria e l’esperienza si sovrappongono e si confondono, in una dimensione che li comprende tutti contemporaneamente.
 La prima volta mi capitò quando assaggiai le mince pies. Ero a Londra, era quasi Natale e c’era la neve, ma quelle sconosciute tortine mi riportarono, contro ogni mio volere o aspettativa (che era invece di approfondimento della cultura britannica) in Sardegna, e quelle pies si sovrapposero in un istante al pan’e saba. Esistevano contemporaneamente: erano una cosa uguale e diversa allo stesso tempo.
La prima volta mi capitò quando assaggiai le mince pies. Ero a Londra, era quasi Natale e c’era la neve, ma quelle sconosciute tortine mi riportarono, contro ogni mio volere o aspettativa (che era invece di approfondimento della cultura britannica) in Sardegna, e quelle pies si sovrapposero in un istante al pan’e saba. Esistevano contemporaneamente: erano una cosa uguale e diversa allo stesso tempo.
Galeotta fu la sapa, e chi ce la mise.
L‘ultima volta mi è successo di recente a Cape Town.
C’è una cucina strana, da queste parti: si chiama Cape Malay e prende il nome dalla comunità omonima che vive nel coloratissimo quartiere di Bo Kaap (vedi foto sopra).
I loro antenati giunsero in Sudafrica come schiavi, con biglietto omaggio della Compagnia olandese delle Indie orientali, dall’attuale Indonesia, soprattutto da Giava e da Malacca, e da tutte le numerose colonie indiane.
Cape Town era una stazione di rifornimento, in posizione strategica tra l’Asia e l’Europa, dove le navi si fermavano per fare rifornimento e smistare merci e schiavi, mentre i marinai si sgranchivano le gambe. In quel punto di intersezione tra mondi così diversi, le varie etnie e culture si mischiarono: genti provenienti da Madascar, dall’Africa, dall’India meridionale, dall’Indocina e da tutto l’arcipelago dell’Asia sudorientale.
Una storia molto simile a quella della cultura africana che si innesta in quella brasiliana, a Bahia, quella raccontata da Jorge Amado, di cui parlo nel mio libro In cucina con Dona Flor, dove l’immigrazione forzata di schiavi africani generò una serie di potenti contaminazioni con la cucina, musica, danza, la religione.
(non finirà mai di meravigliarmi quanto ogni cucina del mondo si porti scritti addosso i secoli di storia che l’hanno preceduta.)
La stessa cosa è successa in Sudafrica.
Prendete il bobotie, per esempio. È un piatto tradizionale molto antico e famoso, ed è una sorta di sformato di carne, speziato dolce-salato, con tanto di pedigree (secondo Wikipedia risale almeno al 1609!)
È anche un buon esempio di quell’Aleph gastronomico di cui parlavo prima, qualcosa che non assomiglia a nulla e allo stesso tempo assomiglia a tutto, che sembra contenere tutto. Il curry si mischia alle uvette, al peperoncino, la carne alle albicocche e alle cipolle, il tutto coperto di una crema di latte e uovo.
Idem per il tomato bredie, uno stufato di montone di origine olandese, profumato di cannella, cardamomo, zenzero e chiodi di garofano, zucchero e peperoncino, o per i Sosatie, spiedini di agnello o montone marinati con cipolle peperoncino, aglio, foglie di curry e tamarindo, cotti alla brace in compagnia di albicocche, cipolle, prugne e peperoni.
Mi arrendo: io questi sapori non ve li so descrivere.
La mia unica possibilità è che esista un sesto gusto dopo l’umami, un gusto in cui dolce e salato si uniscono e creano qualcosa al di là di se stessi.
Se esiste, è qui.
Copyright: photo by Ignis2 @ outdoorphoto.co.za

Lascia un commento